Dal Sillabo alla “legge Zan”. In dialogo con Mattia Lusetti
Come dice bene Mattia Lusetti, nei due articoli (qui e qui) dedicati ad una serrata discussione intorno alla cosiddetta “Legge Zan”, nessuno dovrebbe cadere nella trappola di dividere il mondo in “buoni e cattivi” a seconda che si sia o meno favorevoli ad una legge. Così lui, che di per sé sarebbe collocato dalla parte dei “cattivi”, cerca di uscire dagli stereotipi che i “buoni” tagliano su misura su di lui; da parte mia, che partirei piuttosto dalla parte dei “buoni”, cerco di intercettare queste sue fatiche e provo ad aggiungere qualche prospettiva alle tante cose di rilievo che ho letto nel suo testo.
Parto però da lontano. Perché a mio avviso, in materia di identità, sessualità, genere e diritti, quando scriviamo come cattolici, e tanto più come filosofi o teologi, dobbiamo scontare un “gap” che deriva precisamente dalla nostra storia, dalla nostra tradizione e dalla nostra chiesa. Vorrei partire con il citare il modo con cui uno dei documenti più influenti sulla tradizione cattolica nel XIX secolo, il Sillabo (1864), fotografava un errore “decisivo” nella maniera con cui la cultura liberale di quel tempo intendeva la legge. Ecco la definizione dell’”errore”:
LIX. Il diritto consiste nel fatto materiale; tutti i doveri degli uomini sono un nome vano, e tutti i fatti umani hanno forza di diritto.
A distanza di 150 anni questo testo resta altamente istruttivo, perché non descrive soltanto una “opzione erronea”, ma anche la reazione preoccupata a questa opzione. Contro una riduzione del diritto al fatto, si difende, non senza buon fondamento, la differenza del diritto dal fatto. Questo è un argomento che certo preesisteva al Sillabo e che è arrivato fino a noi. E che resta, sotto traccia, anche dopo il documento che nel Concilio Vaticano II, ne ha superato la logica, ossia il decreto Dignitatis Humanae. Che assume la storia della libertà come significativa per l’accesso alla rivelazione, alla verità e al dovere. Poco prima di quel testo, tuttavia, nell’ultima sua Enciclica, Giovanni XXIII aveva usato, in modo molto semplice, il concetto di “segni dei tempi”, ossia di “fatti” che permettono alla Chiesa di conoscere meglio la propria stessa tradizione:
“è diffusa assai largamente la convinzione che tutti gli uomini sono uguali per dignità naturale. Per cui le discriminazioni razziali non trovano più alcuna giustificazione, almeno sul piano della ragione e della dottrina; ciò rappresenta una pietra miliare sulla via che conduce all’instaurazione di una convivenza umana informata ai principi sopra esposti. Quando, infatti, negli esseri umani affiora la coscienza dei loro diritti, in quella coscienza non può non sorgere l’avvertimento dei rispettivi doveri: nei soggetti che ne sono titolari, del dovere di far valere i diritti come esigenza ed espressione della loro dignità; e in tutti gli altri esseri umani, del dovere di riconoscere gli stessi diritti e di rispettarli.”
Il cammino che nei rapporti di lavoro, nel ruolo delle donne e nella emancipazione dei popoli si realizza apre la Chiesa ad una singolare rilettura della propria dottrina e del proprio “depositum”. I fatti possono chiarire i diritti, i doveri e i doni.
I diritti da riconoscere, i doveri da garantire, i doni da condividere
Le due affermazioni di Pio IX e di Giovanni XXIII, che stanno tra loro quasi esattamente ad un secolo di distanza, configurano, in certo modo, un grande mutamento di paradigma nella maniera di comprendere la legge, la sua funzione e le possibilità di riforma. I diritti umani ridotti a “deliri umani” (Pio X) sono la eredità della impostazione del Sillabo, che rimane ancora ben ancorata nel Codice del 1917 e che solo il Codice del 1983 ha iniziato a rielaborare. Ma la cultura cattolica è rimasta catturata da un “sospetto verso la affermazione e il riconoscimento dei diritti”, nonostante le intuizioni poderose che Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II hanno comunque introdotto nel suo linguaggio e nella sua sensibilità. Cionondimeno ha le sue ragioni Mattia Lusetti nel prendere le distanze da una “cultura omologata” che applaude solo ad un nuovo diritto riconosciuto. Credo che la reazione, dal punto di vista ecclesiale, non debba mai avere riserve sul riconoscimento del diritto, ma solo sul suo raccordo con il dovere e con il dono. Qui, io credo, la vocazione comunitaria della Chiesa non deve perdere forza e argomenti. Non però negando il diritto, ma accompagnandolo con il dovere e con il dono. Questa correlazione, irrinunciabile, deve però poter cominciare dalla libertà. Questa è la sfida: non aver paura di cominciare – certo sempre astrattamente – dalla libertà, senza pretendere che sia sempre una “falsa partenza” o in “inganno” o una “forma capovolta di autoritarismo”, come pure può essere di fatto. Ma non lo è “per principio”. Noi, dobbiamo riconoscerlo, siamo gli ultimi a poterlo dire preventivamente. Lo abbiamo fatto troppo ostinatamente per 100 anni (almeno in prevalenza): ora dobbiamo cambiare stile, come ci ha insegnato papa Giovanni e il Concilio Vaticano II e come da loro ha imparato papa Francesco.
Una singolare coincidenza
Potrà apparire singolare coincidenza che, in questi stessi giorni, si discuta allo stesso tempo di una legge penale dello Stato italiano e “non si discuta” della riforma della legge penale canonica. Infatti da un lato si solleva una giusta interrogazione che riguarda la Chiesa ad extra e ad intra e che mira a contribuire ad un avanzamento delle tutele dei soggetti senza compromettere la possibile espressione ed esperienza dell’intero corpo civile; ma dall’altro si assiste alla presentazione di una riforma senza dibattito, senza confronto, puramente interna. La divisione dei poteri e il potere indiviso ha i suoi vantaggi e svantaggi. E ci propone un singolare contrasto! A ciò vorrei aggiungere anche la diversa concezione della “sanzione penale” in ambito civile e in ambito ecclesiale. La elaborazione di un “sistema dei delitti e delle pene” in ambito statale ha indirettamente una funzione pedagogica, che resta però in secondo piano sia nella amministrazione della giustizia, sia nelle forme di applicazione e di sconto delle pene. In ambito ecclesiale, invece, il sistema penale è sempre in relazione con il sistema penitenziale. Senza avere un proprio “penitenziario”, la Chiesa ha nella penitenza un luogo di assoluzione dalle colpe che strutturalmente entra in concorrenza – virtuosa o viziosa – con il “sistema penale”. Questo sta scritto nel DNA della Chiesa e trova, in una serie di vicende recenti, legate soprattutto agli abusi sessuali, il suo punto cieco e di crisi. Una gestione “in foro interno” del dramma degli abusi ha causato spesso abusi peggiori. Qui clericalismo, sistema amministrativo, diritto penale e teologia si sono incrociate, alleate o scontrate. Ma una struttura “di foro esterno”, che riesca ad importsi, implica un profondo mutamento non solo delle procedure, ma della “mens” ecclesiale. Certezza della pena e diritti dei terzi sono, in campo ecclesiale, parole dal significato non così semplice, perché vengono da altri mondi e da altre forme di relazione personale e comunitaria. Oggi, invece, urge rispondere in modo autorevole proprio su questo piano.
La difesa dei diritti e le garanzie della dottrina
Nel suo testo Mattia Lusetti, in un passaggio interessante, pone una delle questioni che sono state sollevate sulla “legge Zan”, non solo da parte cattolica: con la affermazione dei diritti che la legge garantisce, non potrebbe esserci un fenomeno capovolto di “emarginazione” di forme di pensiero o dottrine che non sono “in linea” con il vocabolario che la legge propone come normativo? Non si può sottovalutare la questione. Che però proporrei di impostare in modo meno drastico. Riprendo brevemente le parole precise di Mattia, per commentarle. Egli parla, per la legge così come è formulata, di
“concreto pericolo di predisporre de facto dei reati di opinione. Ci si potrà dichiarare convinti di quello che è l’insegnamento della Chiesa sull’omosessualità? Si potrà scegliere questo paradigma educativo?”
Ed è evidente che, così come formulata, la domanda tocca un punto sensibile. Ma forse la urgenza del problema può essere non dico superata, ma almeno smussata, se non si entra nella piccola tentazione di fare dell’insegnamento della Chiesa sulla omosessualità una specie di “monolite” che non ha nulla da imparare, che non ha “segni dei tempi” da riconoscere o “storie di vita” da ascoltare e su cui meditare. Come la la omossessualità fosse una “definizione dogmatica” e non una “forma di vita”. Che una legge dello stato, quando stabilisce nuove forme di diritti da rispettare da parte di tutti, possa essere percepita solo come “minaccia” e non come “opportunità” sembra essere una reazione pensata più secondo il modello del Sillabo, che secondo il modello di Pacem in terris o di Dignitatis Humanae. Ma non è affatto detto – ed anzi io sono convinto – che anche l’insegnamento della Chiesa sulla omosessualità abbia anche qualcosa da imparare dalle forme civili di vita, così come è accaduto per la relazione intrafamiliare, che ha scoperto, solo con Giovanni XXIII, la “parità tra marito e moglie”, desumendola non dai testi della Scrittura o della tradizione ecclesiale, ma dal grande testo della Dichiarazione dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite.
Con questo non dico affatto che nel testo di Mattia Lusetti si resti nella nostalgia di un modello solo pedagogico di legge. Anzi, vi sono i chiari segni di un vero tentativo di dialogo con le ragioni dell’altro. Ma dico che la fatica di un confronto con “nuovi diritti” non deve mai cedere alla possibilità di ridurli ad una semplice illusione. E’ proprio la tradizione ecclesiale a sapere bene i limiti della legge penale e a non chiedere troppo alle sanzioni. Ma la tradizione civile ci insegna, a sua volta, che un eccesso di discrezionalità, nel riconoscere i diritti o nel perseguire i crimini, non tutela a sufficienza i terzi e rende poco efficaci anche le migliori intenzioni. Per questo nuove leggi civili, per quanto criticabili e giustamente discusse, possono riconciliare la Chiesa non solo con il suo volto di maestra, facendola meditare a fondo sul rivestimento contingente della propria dottrina, ma anzitutto con quello di madre, e così ritornando con determinazione alla sostanza della antica dottrina del depositum fidei.
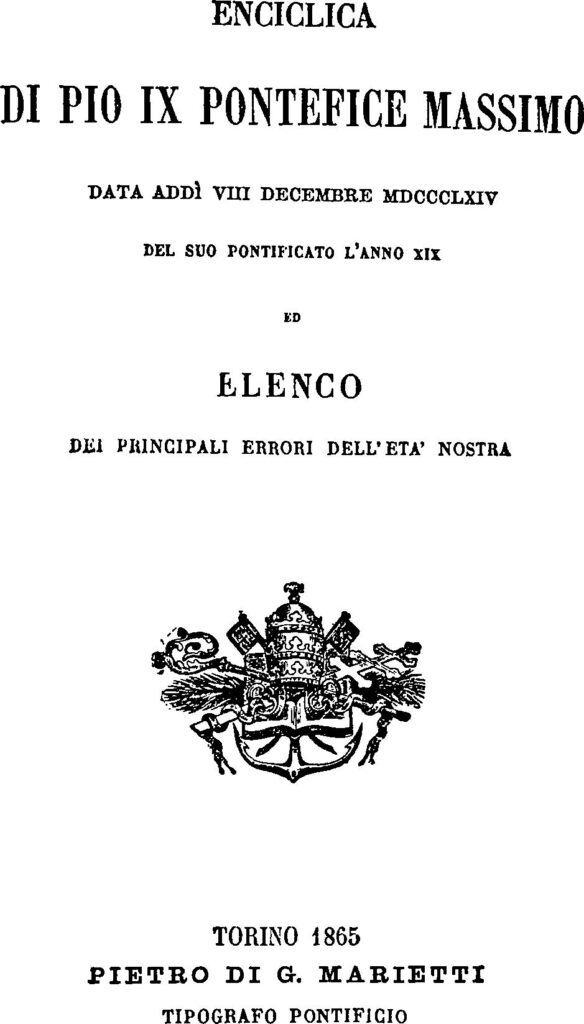
E come non dovrebbe la Chiesa dimostrarsi attenta anche e proprio di una Legge dello Stato che una volta promulgata diventa diritto-dovere per tutti i cittadini alla osservanza?La Chiesa Se anche facesse di un insegnamento, non importa in quale campo, un “monolite”, questo non discende da Lei, da un suo giudizio, ma da attenta interpretazione delle Sacre Scritture. In “Veritatis Splendor” al n.18 di G.P.II, molto e approfondito circa a quale libertà l’Uomo è chiamato a rispondere di fronte al Dio Creatore, e per quale finalità e quanto questa comporti. tanta luce serve alla mente di chiunque desidera discernere,aprirsi a conoscenza per meglio decidere. Infatti dai “segni dei tempi” da riconoscere e storie di vita da ascoltare, sono preoccupazioni , cura a che al Vangelo sia data testimonianza da tutti per il bene di tutta l’umanità. Opera di Cristo del quale e dichiarata Sposa. siamo liberi di decidere, non in virtù di una legge, ma per un più libero consenso